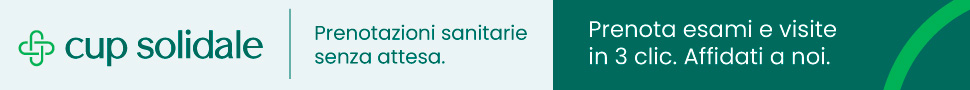L’uveite è una malattia che si presenta come idiopatica, ovvero priva di una causa identificabile con certezza, anche in presenza di un’accurata visita specialistica.
Tuttavia, esistono numerosi fattori noti che possono contribuire all’insorgenza dell’infiammazione. Le cause si distinguono generalmente in infettive, sistemiche, traumatiche e farmacologiche.
Le cause infettive dell’uveite possono essere correlate a virus, batteri, funghi e parassiti. Gli agenti patogeni che più comunemente possono portare all’uveite infettiva sono il virus dell'herpes simplex, il virus della varicella-zoster (VZV), la toxoplasmosi, la sifilide, la tubercolosi e il citomegalovirus (CMV).
Malattie sistemiche che più spesso causano l’uveite, invece, sono la sarcoidosi, una patologia infiammatoria a componente autoimmune che causa il 25% dei casi di uveite con sintomi che differiscono in base alla localizzazione dell’infiammazione, il lupus eritematoso sistemico, l’artrite idiopatica giovanile, sclerosi multipla, malattia di Behcet, malattie infiammatorie intestinali (colite ulcerosa e morbo di Crohn), l’artrite psoriasica e la spondilite anchilosante, una forma di artrite che colpisce la colonna vertebrale.
Anche alcuni farmaci immunoterapici, chemioterapici, antibiotici e antivirali possono causare uveite. Tuttavia, la causa più comune di uveite sono i traumi oculari, che possono innescare la reazione infiammatoria dell’uvea.